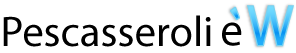C’era una volta il West in Alto Sangro. Ricordi del passato cinematografico di Opi e Pescasseroli tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso
Poco più di un anno fa, il 28 marzo del 2024, nelle sale cinematografiche italiane usciva Un mondo a parte, il film del regista Riccardo Milani che ha mostrato a più di un milione di persone le bellezze naturali, i paesi e gli abitanti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’incontro tra i paesi del Parco e il mondo del cinema non risale però all’anno scorso, ma è più antico. Difatti, il presente articolo intende ricordare quattro film che furono girati tra i suggestivi territori di Opi, Pescasseroli, Bisegna e Scanno tra il 1948 e il 1968: Il cavaliere misterioso (1948), Uomini e lupi (1957), Annibale (1959) e Quanto costa morire (1968).
Inoltre, prima di iniziare a parlare dei film appena citati e di porre l’attenzione sui luoghi delle nostre montagne in cui diverse scene furono girate, occorre rammentare che l’Alto Sangro fu intimamente amato da alcuni illustri rappresentanti del mondo del cinema italiano poiché Pescasseroli, nei primi anni Sessanta, era già il luogo di villeggiatura dello sceneggiatore Agenore Incrocci (meglio noto con il nome d’arte Age) che fece conoscere la Capitale del Parco al regista Ettore Scola, scomparso nel 2016 a cui la comunità pescasserolese ha voluto intitolare il proprio cinema nel gennaio del 2017. Effettivamente, il fascino di Pescasseroli, che proprio in quegli anni, sull’onda del miracolo economico, abbandonava repentinamente le ultime spoglie dell’atavico passato agropastorale per consacrarsi al nuovo sviluppo turistico, destò in Ettore Scola e nella sua famiglia il desiderio di acquistarvi una villa dove passare sia i momenti di riposo che quelli di lavoro. Così, come ricorda Silvia Scola, figlia del noto regista, in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Foglio, la loro residenza di Pescasseroli era abitualmente frequentata anche dai grandi nomi del cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta tra i quali è possibile ricordare gli attori Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Marcello Mastroianni, i registi Dino Risi e Federico Fellini e gli sceneggiatori Age e Scarpelli.[1]
Il primo film girato tra le faggete dei boschi di Pescasseroli e Opi di cui si abbia notizia è il Il cavaliere misterioso, una spy story ambientata attorno la metà del XVIII secolo che venne distribuita nelle sale cinematografiche italiane il 1°novembre del 1948. Nella pellicola in questione, fra gli attori principali figura un emergente Vittorio Gassman, all’epoca ventiseienne, che nell’anno successivo (1949) si sarebbe imposto nel panorama del cinema internazionale con l’interpretazione del losco personaggio di Walter Granata in Riso amaro. Invece, ne Il cavaliere misterioso, Gassman interpreta l’elegante Giacomo Casanova impegnato in un’operazione di spionaggio internazionale con il fine di salvare suo fratello, ingiustamente accusato del furto di una preziosa lettera contenente le prove di un pericoloso piano politico ordito dall’imperatrice Caterina II di Russia mirante a sottrarre alcuni territori alla Repubblica di Venezia.
La trama del film, che denota una chiara impostazione antisovietica dovuta alle dinamiche della guerra fredda, si dipana tra Vienna, la Russia e Venezia. Proprio nelle scene ambientate in Russia il paesaggio dell’Alto Sangro è maggiormente riconoscibile con le sue faggete che fungono da sfondo alla caccia all’orso organizzata per il divertimento dell’imperatrice di Russia. Ma è nella scena più movimentata dell’intero film, ovvero quella dello spericolato inseguimento da parte dei cosacchi della slitta guidata da Casanova, che si riconoscono distintamente le curve e i rettilinei della strada che dal valico di Forca d’Acero scende verso Opi. Al riguardo, l’intera sequenza offre suggestive visioni di Monte Marsicano innevato la cui imponenza traspare anche attraverso la pellicola in bianco e nero.

Figura 1 – Fotogramma che mostra il momento del film durante il quale la slitta, guidata da Casanova, viene inseguita dai cosacchi dell’imperatrice Caterina.
Nel 1957, nove anni dopo la produzione de Il cavaliere misterioso, le nevi che imbiancano abitualmente l’Alto Sangro tornarono ad essere mostrate nelle sale cinematografiche di tutta Italia con la distribuzione del film Uomini e lupi. In questa pellicola, nella quale si avverte lo spirito neorealista conferitole dal regista Giuseppe De Santis, viene narrato l’evolversi della storia d’amore tra il luparo Ricuccio, interpretato dall’attore italo-francese Yves Montand, e Teresa, nella realtà la grande Silvana Mangano. La cornice che fa da sfondo ai due protagonisti è quella di un Abruzzo montano fuori dal tempo che sembrerebbe quasi di ispirazione dannunziana se non fosse per la rappresentazione della vita povera, ma dignitosa, dei montanari che animano le scene del film.

Figura 2 – Fotogramma iniziale del film Uomini e lupi in cui si può chiaramente riconoscere il caratteristico abitato di Scanno.
Molte delle riprese esterne furono girate a Scanno, che nel film prende il nome fittizio di Vischio, e lungo le sponde dell’omonimo lago. La neve è quella che realmente cadde durante la storica nevicata del ’56, ancora viva nella memoria di chi nacque a cavallo tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta.

Figura 3 – Fotogramma del film Uomini e lupi nel quale si vede il personaggio di Teresa (Silvana Mangano) condurre il proprio carro lungo la strada che costeggia il lago di Scanno.
Per quanto riguarda il territorio alto sangrino, alle Pagliara di Opi fu girata la scena che vede l’istrionico Ricuccio cercare di convincere, senza molto successo, gli abitanti del posto a elargire a lui e a Teresa un generoso compenso in natura per aver svolto le proprie mansioni di cacciatore di lupi.

Figura 4 – Le Pagliara di Opi con le Prata sullo sfondo nel film Uomini e lupi.

Figura 5 – Fotogramma del film Uomini e lupi nel quale Ricuccio (Yves Montand) e Teresa (Silvana Mangano con addosso la pannuccia) interloquiscono presso le Pagliara con una donna ch’i fazzëlèttë ngapë. Da notare sulla sinistra come un uomo del paese indossa i pëllëcciónë, un giubbotto in lana di pecora tipico dei pastori.
Un paio di anni dopo il mondo del cinema si inerpicò nuovamente lungo le strade alto sangrine per girare questa volta le scene di Annibale, un film appartenente al genere epico-storico che venne proiettato nelle sale cinematografiche nel 1959. Come si evince dal titolo, la pellicola in questione verte sul personaggio storico di Annibale (interpretato dallo statunitense Victor Mature), che nel 218 a.C., nell’ambito della seconda guerra punica, diede inizio all’invasione dell’Italia romana varcando l’arco alpino nord-occidentale con il suo esercito del quale facevano parte anche alcuni elefanti destinati a rimanere nell’immaginario collettivo di ogni epoca successiva. Così le scene dell’epica traversata della catena alpina non furono girate tra le Alpi piemontesi (troppo lontane da Cinecittà), ma furono in gran parte ricreate nel pianoro di Terraegna, nel territorio di Pescasseroli, o presso la Foce di Opi.

Figura 6 – Fotogramma del film Annibale in cui il pianoro di Terraegna funge da sfondo alle colonne annibaliche in marcia.
Nel film Annibale la sequenza della traversata delle Alpi dura quasi un quarto d’ora durante il quale si può osservare come alle comparse, assoldate tra i giovani di Opi e Pescasseroli, venne fatto indossare i cappóttë a ròta, ancora diffuso nelle case degli opiani e dei pescasserolesi alla fine degli anni Cinquanta.

Figura 7 – Fotogramma del film Annibale nel quale è visibile il colletto del cappóttë a ròta indossato da una comparsa.

Figura 8 – Una comparsa del film impegnata a risalire una parete rocciosa.
Al fine di trasmettere al pubblico tutta l’epicità della traversata annibalica delle Alpi vennero ricreate alcune scene drammatiche nelle quali i soldati di Annibale, poco avvezzi a muoversi in mezzo alla neve, precipitano nei profondi burroni che si aprono ai bordi dei ripidi sentieri.
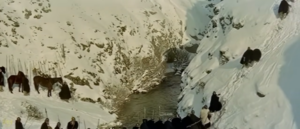
Figura 9 – La scena in cui i fanti e i cavalieri cartaginesi sono intenti ad attraversare una gola impervia fu girata presso la Foce di Opi.

Figura 10 – Il Monte Marsicano fa da sfondo alla difficile ascensione in mezzo alla neve dei soldati punici.
Coloro che erano dei bambini quando furono girate le scene di questo peplum ricordano ancora il divertimento nel vedere le grosse ventole in azione per ricreare l’effetto di una bufera di neve o le silhouettes degli elefanti, create con grandi sacchi, avanzare su carrelli muniti di ruote. Oltre a ciò, le punte di lancia in gomma lasciate dalle maestranze sui luoghi delle riprese erano molto ambite dai bambini dell’epoca che le riutilizzavano nei loro giochi fantasiosi.[2]

Figura 11 – Il viso di una comparsa truccato per ricreare le ferite mortali procurate dalla caduta in uno strapiombo.
La sequenza della traversata alpina si conclude con una panoramica della Pianura Padana che si estende dinanzi gli occhi del Cartaginese. In realtà, la pianura filmata è quella del Fucino vista da Gioia Vecchio.[3]

Figura 12 – Fotogramma finale della traversata delle Alpi nel quale la pianura che si vede in lontananza è in realtà quella del Fucino.
Verso la metà degli anni Sessanta il grande pubblico perse l’interesse nei confronti del genere epico-storico ambientato nel mondo classico che venne di conseguenza presto abbandonato dall’industria del cinema. Inoltre, a partire dal 1964 e fino al 1978 in Italia ebbe molto successo il genere cinematografico del cosiddetto western all’italiana. Difatti, Quanto costa morire, l’ultimo film di cui si intende parlare nel presente articolo, può essere inserito a pieno titolo fra i numerosi spaghetti western realizzati in Italia fra gli anni Sessanta e Settanta. Anche questa pellicola, risalente al 1968, fu girata nell’Alto Sangro, per la precisione nel territorio di Opi.

Figura 13 – Fotogramma iniziale del film Quanto costa morire in cui si possono riconoscere Val Fondillo e Serra delle Gravare.
Quanto costa morire fu girato nel marzo del 1967 e coinvolse gli abitanti di Opi e i loro animali domestici. Ad esempio, per le scene del furto di bestiame realizzate a Val Fondillo e a Valle Fredda furono necessarie una cinquantina di vacche appartenenti a varie famiglie del paese. Tutte le comparse, sia quelle umane che quelle animali, venivano retribuite con un compenso giornaliero di 1.000 lire.[4]

Figura 14 – Le Pagliara tornarono ad ospitare un set cinematografico.
Le Pagliara, il complesso di stalle edificato ai piedi del colle sul quale sorge l’abitato di Opi, divennero, nella finzione cinematografica, uno sperduto villaggio di frontiera del Colorado la cui popolazione è costretta a subire la presenza molesta di una banda di ladri di bestiame rimasta bloccata a causa della neve. Il gruppo di criminali, comandato dal sadico Scaife, in realtà l’attore Bruno Corazzari, sottopone gli abitanti del villaggio a diversi soprusi fino a quando Tony (l’attore Andrea Giordana), figlio adottivo dell’ex sceriffo Bill Ransom, non si ribella e riporta l’ordine e la giustizia tra la sua comunità.

Figura 15 – Fotogramma del film in cui Domenico Sgammotta (Mëngóscë), allora un bambino di 8 anni, recita nei panni di un giovanissimo abitante del villaggio obbligato ad assistere uno dei più crudeli membri della banda di Scaife durante il pasto.

Figura 16 – Presso la pineta della località l’Arë i Lózzë, venne girata la scena in cui alcuni taglialegna del villaggio, ribellandosi al dominio tirannico del gruppo di criminali, si uniscono a Tony.
La pellicola Quanto costa morire, come tutti i film western che si rispettino, termina con la vittoria dei buoni. Difatti, mediante una sparatoria, Tony e gli abitanti del villaggio riescono a sgominare tutti i banditi eccetto il temibile Scaife che viene ucciso in un classico duello con la pistola da Dan El (l’attore John Ireland), suo amico di vecchia data nonché vero padre di Tony.

Figura 17 – La convulsa sparatoria che si consuma alle Pagliara. Anche a questa scena diversi opiani presero parte in qualità di comparse.

Figura 18 – Fotogramma finale del film nel quale è possibile riconoscere la località del territorio di Opi nota come il Coppo (i Cóppë in dialetto opiano), situata nei pressi della SS 509 per Forca d’Acero.
Nonostante al giorno d’oggi quasi tutte queste pellicole siano poco ricordate, non bisogna dimenticare che per alcune di esse (Il cavaliere misterioso e Uomini e lupi) all’epoca dell’uscita nelle sale cinematografiche si registrò un discreto successo di pubblico e di critica grazie sia a una valida regia supportata da una brillante sceneggiatura che a una talentuosa recitazione da parte di attori del calibro di Vittorio Gassman[5] e Silvana Mangano[6]. Il rapporto tra gli splendidi scenari del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il mondo del cinema non è terminato cinquanta anni fa, ma è continuato anche in anni più recenti e ciò è testimoniato da film quali Auguri professore (1997) e Il posto dell’anima (2003), entrambi del regista Riccardo Milani. Si può quindi ritenere che in futuro i registi trarranno ancora ispirazione dalle particolari atmosfere emanate da luoghi la cui unicità si manifesta sotto molteplici aspetti.
[1] V. Fantasia Giuseppe, Pescasseroli e il cinema, una storia oltre lo schermo (22/03/2024), in www.ilfoglioit.
[2] Per questa informazione si ringrazia Giovanni Pietro Boccia.
[3] Per questa informazione si ringrazia Nunziato Di Santo.
[4] Per questa informazione si ringrazia Remo Cimini che prese parte alle riprese del film.
[5] Per la scheda del film Il cavaliere misterioso v. Il Cinema Ritrovato.it.
[6] Per la scheda del film Uomini e lupi v. Archivio Film della Rete Civica del Comune di Reggio Emilia.