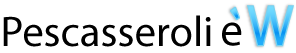“La terra delle donne”, la Sardegna delle donne, l’omaggio alle donne
Al Bari International Film Festival la regista Marisa Vallone e la sua squadra sono passati all’incasso facendo incetta di premi con la pellicola “La terra delle donne”. Svetta tra tutti l’attrice protagonista Paola Sini che agguanta il premio “Premio Mariangela Melato” come miglior interpretazione femminile. Sua la bacchetta magica da cui è nato un pezzo magistrale che è un caleidoscopio di significati. E la bravura di Vallone e Sini che lo hanno confezionato è stata di non dare adito a depistaggi. Il senso non è rinchiuso in un tabernacolo inviolabile, piuttosto è la rosa nella teca che ciascuno può ghermire. Il film omaggia le donne, creatrici di vita e di cosmi. Dinanzi, lo sguardo maschile diventa liquido e si immerge anch’esso; da lì in poi non può più ammutolire.
Sardegna, terra di mescolanza di brunito e cinerino. Anni 30, un’epoca adamitica ormai, di Bibbie e breviari e non di elettronica. Eppure la dama degli incastri di ruoli sociali ci vieta di operare una recisione netta con il presente. La chirurgia antropologica è stata un lavoro a fil di lama: occhiuta, scrupolosa per tirare fuori dal cilindro del tempo che risucchia un mondo che deve essere sottratto all’oblio. Quel mondo ancestrale, in cui l’Uomo ha addosso ancora l’umidità della terra da cui è stato creato, ce l’abbiamo attaccato ai piedi come l’ombra di Peter Pan. Aguzzando lo sguardo c’è tutto da imparare. Per questo “La terra delle donne”, impastato di polvere in ogni inquadratura, ammalia, sembra la fibra dietro la filigrana per leggere l’oggi attraverso il passato. Nessun barocchismo, il significato è limpido, puoi coglierlo anche senza la lettura dei simboli graffitati. La donna, catalizzatrice di ogni senso e magia. La donna è aggiogata all’imperativo della maternità. Nessuno scampo, nessuna deroga e persino nessuna proroga: deve procreare. È Eva e deve garantire la prosecuzione prima ancora che del genere umano della tribù familiare. E quando il ventre è ingeneroso e non sforna figli maschi, il gineceo domestico diventa maledetto: la settima figlia deve riparare a questa peste, ricreare un’aura. Lo fa indossando tessuti francescani: diventa la “coga”, la strega del paese. È l’unico suo passaporto per esistere e nello stesso tempo la sua lettera scarlatta. È richiesta per gli esorcismi, un potere che sembra un residuo e invece è quello di una burattinaia che intreccia i fili delle vite. Salva, fa abortire, uccide, devasta, scompiglia seguendo la lettera del suo breviario. Tutto nella nudità che affligge quando ci si spoglia di tutti i sentimenti: tutto questo per il “ruolo”, quel saio stretto in cui solo si può vivere e saturato di carne e sangue. Carne, solo carne e non autentico corpo: ce lo dice Fidela che nei suoi voli rasoterra della femminilità si concede momenti di sessualità. Più sventurata è sua sorella Marianna che resta suo malgrado ostracizzata da questa scacchiera perché amenorreica: non è donna, non sarà mamma, non è nessuno. A lei la disperazione di diverso colore, ma con la stessa dissonanza di quella di Anna Karenina di cui ricopia in lucido il destino.
Bastiana la bionda: è un premio per Fidela? La bimba, la ragazza, poi la donna che le viene affidata, perché anche questa ha una tara da emendare, diventa la sua pupilla con cui può svolgere un apprendistato di madre. Una vita che si affianca alla sua, entro gli argini della dannazione, con dei contatti o con delle divaricazioni, anche. Bastiana però scalpita, la tagliola del ruolo incompreso la fa lacrimare e urlare. Dell’esistenza vuole squarci, quelli delle fotografie, e non il potere di regolare le porte girevoli della vita. Cova dentro il sentimento rosaceo più profumato: l’amore per se stessa. E non ci sarà bisogno di altro filtro per la sua favolosa metamorfosi finale. Si parte da un’alzata di spalle, poi l’aculeo del coraggio: così Fidela si decide a salpare, a fare in modo che il vento marino graffi le sue catene. Altra terra, un’altra lei e un mondo che è un ventaglio immenso di possibilità per poter essere senza l’imposizione di nessun decalogo. È tutta lì, è tutta lei.
I luoghi sono a misura di inquadratura, come una scenografia ricostruita su una ribalta teatrale. Se non ci fosse lo scorrimento dell’acqua l’occhio non dovrebbe troppo immaginare. E invece, con la sua presenza ridondante, l’acqua ci trascina, ci ossessiona, ci scava al pari del granito. Sfonda il grembo di quelli idilli cinerini, il grembo del laghetto, della caverna prima che esso si richiuda ad ingabbiare perle di vita.
FEDERICA TUDINI