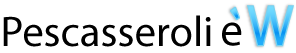In Siria con Susan Dabbous. La sua esperienza in “Profeti” di Alessio Cremonini
Quanto poco spazio c’è nella nostra mente per empatizzare davvero con qualcuno? Ma a volte si incontrano delle storie ed è come un tamponamento. Vieni scalzato dalla comodità: la Storia sta accadendo. Tutto ciò che era urgente lo è diventato troppo tempo dopo. Abbiamo girato pagina quando si è trattato della guerra in Siria come fosse un fenomeno a bassa intensità, ma Susan Dabbous ha ancora voce e se è qui è perché si fida di noi.
Cosa può donare questo film?
Questo film è tante cose. Sicuramente lascia un senso di curiosità su un mondo per certi versi remoto. Un mondo che viene raccontato sempre per stereotipi. La prigioniera vi entra dentro e ne conosce le sfaccettature più complesse. Questo film apre la finestra su un mondo oscuro, violento ma nella sua complessità anche molto umano. Fa parte di un’umanità che appartiene comunque alla nostra specie. In molti altri film, ovvero quei pochi sull’argomento, la violenza viene molto semplificata.
Qual è il compito di una giornalista siriana?
Io non mi sono mai definita una giornalista siriana perché non ho mai vissuto in Siria. Il fatto di essere italo-siriana e di avere delle connessioni familiari e culturali con la Siria non è dirimente perché linguisticamente e culturalmente non appartengo a questo Paese. Posso però dire che per i giornalisti siriani è stato un inferno, ma anche un momento di sperimentazione di scrittura e di reporting libero. Grazie a loro si è acceso un faro sui metodi violenti e le aberrazioni del regime. Molti hanno pagato con la vita. Va dato atto a chi ha avuto molto coraggio e ha scritto e filmato queste atrocità di cui tutto il mondo è venuto a conoscenza. La guerra siriana è finita sotto la lente d’ingrandimento di tutte le organizzazioni internazionali. Quindi ti posso dire di loro. Io sono andata in quel contesto come giornalista italiana. Tra i giornalisti italiani molti sono stati rapiti. All’inizio sembrava di potersi avvicinare al contesto siriano con facilità perché più prossimo anche geograficamente, ma poi si è rivelato altamente rischioso fino ad essere una trappola mortale.
Com’è stato vivere l’esperienza del rapimento?
È stata un’esperienza che ha aperto una finestra su un mondo oscuro, violento che viene spesso raccontato in modo frammentato e parziale. Da un lato è stata un’esperienza personale traumatica, dall’altro è stata un’esperienza umana e professionale che ha aperto una finestra su questa realtà. Mi ricorda che il mondo non è esclusivamente quello che viviamo nella nostra esistenza ordinaria: ci facciamo toccare dalle notizie in maniera molto marginale. Quando proviamo a capire abbiamo sempre questo grande limite. La mia esperienza è stata purtroppo di quelle che questi limiti li ha sfondati. In questa immersione totale ho alternato il terrore e la voglia di capire cosa spinge queste persone ad abbracciare delle filosofie di vita e delle ideologie aberranti e che però esistono ed esistono non solo nella declinazione islamica, ma sono rinvenibili in molti altri contesti in cui si pratica una sorta di lavaggio del cervello, il condizionamento, un’educazione manipolatoria, inconcepibili nel mondo libero e che rimangono molto difficili da esplorare e da capire. Sono molto violente, ciononostante bisogna raccontarle con un’attenzione profonda, anche se immergersi in questi discorsi con una certa esperienza alle spalle è molto duro. Tutti gli ostaggi trovano delle strategie interne personali per sopravvivere in questa circostanza.
Cosa ti ha lasciato e come si può continuare la lotta?
Per me è stato fondamentale continuare a scrivere quando facevo giornalismo e poi ho sentito molto forte il richiamo al mondo dell’attivismo e dell’azione umanitaria. È stata davvero una spinta molto forte. Lavoro per un’organizzazione umanitaria e il mio punto fisso è che viene prima l’azione e poi il racconto intorno all’azione. Non può essere un racconto fine a se stesso. Abito degli scenari in cui l’informazione è il miglior viatico e deve sempre andare in solido con l’azione umanitaria. Bisogna parlare di quello che succede e nel nostro ruolo di organizzazione umanitaria divulghiamo ciò che facciamo.