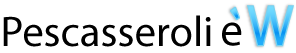Nonno, raccontami dei mestieri di una volta
Foto di Francesco Gentile www.terrepesculiasseroli.it
Questo Millennio è un ladro, ha arraffato tutto quanto faceva parte dell’esistenza di un tempo. Nonostante si sia stato smascherato l’intrigo del benessere, continuiamo ad inseguirlo abbagliati.Gli anni si sono rincorsi, si sono attorcigliati nelle epoche, niente è più come prima, siamo infelici e storditi più di prima. Mentre anelo una via di scampo, cerco l’esodo nel racconto di nonno. “Nonno, raccontami com’era l’economia di una volta!”. Nonno Raffaele prima indugia. I ricordi prima si imbastardiscono poi si ingorgano. Ma poi la sua memoria si popola di nomi, di immagini e a 88 anni nonno andrebbe a falciare il grano come allora, come se tutto fosse uguale nell’eterno ritorno del presente. Una conca bionda stesa sotto il cielo, è il primo idillio che rammemora. Pescasseroli era tutto un granaio che ricopriva le fasce collinari, i Colli Alti, i Colli Bassi e Pizzaun’ e poi si allungava fino a Sand’ Rocc’ e presso le Sp’nelle. I bambini si caricavano l’aratro con la foga degli adulti: si nasceva per lavorare, si cresceva per lavorare e poi si invecchiava per mettere a riposo non la fatica ma l’euforia di vivere ad ogni costo. Il lavoro svezzava e nonno lo ricorda abbozzando un sorriso. La coltura avveniva a rotazione. Il grano veniva ricacciato dalle colline attraverso le “Caiole”, grandi recipienti concavi caricati ai fianchi dei muli, sostituiti al piano dalle carrette. Poi si ammucchiava nelle “Aie” che puntellavano il paese. Da Fucino risalivano per partecipare al maneggio e alla pulitura.
Un’enorme catasta di grano veniva ammassata presso il ristorante Boselli, località che ospitava l’Aia dei Sipari, considerata il fiore all’occhiello della trafila granatiera del paese. Si accatastavano le “casarce” nell’Aia comunale presso l’ufficio postale, e ingombra di “casarce” era pure l’Aia di Boccia. Le spighe venivano incrociate all’interno perché non si bagnassero nell’atmosfera imbrifera. “Le racan’ bastavano appena per le lenticchie”, non potevano essere destinate alla copertura. I Sipari ingaggiavano operai esperti che sapessero incrociare a mestiere le spighe nei mucchi affilati uno accanto all’altro. I buoi servivano a tirare la trebbia. Il grano riposava per quindici giorni e trebbiato nel mese di agosto. Nonno specifica:”Si doveva fare in fretta altrimenti arrivava settembre ed era troppo tardi”. La paglia che residuava dal setaccio veniva data in pasto agli animali. L’ultima fase prevedeva la consegna del grano al mulino per la macinazione. Il mulino che faceva più gola era a Opi: questo mulino poteva godere di riserve di acqua propria ed era esente dalle gabelle, quindi poteva permettersi di ribassare il costo della lavorazione del grano.
Nelle fasi precedenti era previsto un ruolo anche per le donne, le “capa jerva”. “Le femmine districavano l’erba in mezzo al grano alto ottanta centimetri per disincagliarlo dalla zizzania. Altra coltivazione prelibata che sosteneva la dieta dei pescasserolesi era la lenticchia. “A’ Tomm’l” di lenticchie veniva scambiato con i fruttivendoli al posto di verdure, così come la v’renna, la crusca di scarto. Un’economia di transazioni spicciole, non per lauti guadagni ma per la sopravvivenza: il denaro aveva una circolazione ridotta. Solo per la pasta e la “conserva” ci si recava in negozio. Inghiottire il sangue del maiale non può essere ricondotto solo all’esigenza di non sprecare nulla. A tavola si facevano i conti con la maga Vita, era questa che non lesinava nulla e tutto quanto si presentava le andava sottratto come ad un tiranno. Vigeva una filosofia dello scarto, non così ributtante ma anzi prelibato per la ghiottoneria di chi ama la vita, nonostante la precarietà.
La schiera dei vangatori veniva arruolata per scavare delle cunette per permettere lo scolo dell’acqua nei campi per il drenaggio del terreno in modo che il grano non marcisse. Un piccolo gregge di loro si riversava in Puglia per mettersi a servizio nelle vigne oppure a costruire argini presso le scarpate dei fiumi, come il Candeloro. Alzare, ammassare, abbassare la terra, con la vanga che diventava una protesi del proprio corpo. I vangatori andavano via, poi tornavano anche se tornare significava rimettersi a dormire nella casa della miseria. Il ritorno era la loro forma di vita. Dove sei nato, lì muori perché lì ci hai lasciato l’anima, pure se non te ne sei accorto quando sei partito. Tra i vangatori alcuni emergevano e venivano promossi alla missione di programmare il lavoro e smistare le schiatte di operai tra le varie mansioni.
Con “A’ Str’ngatur’” due boscaioli tentavano di buttare giù un albero con tanta fatica e poco denaro in cambio. Cosa significava “tirare a campare”. Avanti e indietro, con la tenacia di chi deve conquistarsi il pane, solo quello. Un obiettivo minimo che a pensarlo prosciugava ogni altra aspettativa. Non il poco o il molto contavano: contava l’abbastanza. Abbastanza pane per mangiare e concludere la giornata con la pancia abbastanza piena. Le mule, operaie di infimo grado ma non molto più in basso dei loro padroni infondo, avevano la delega al trasporto del legname a valle. Solo erano esonerate dal dover inchinarsi per ottenere l’obolo, non sapevano allungare il collo a quel modo come fanno gli esseri umani per essere remunerati. Le famiglie di cavallari possedevano anche cinque cavalli che trascinavano con sé anche nel reatino per ricacciare la legna. Gli scalpellini innalzavano i rifugi per i pastori in montagna. Il calzolaio forgiava per loro scarpe di ferro che avessero lunga durata al piede.
Sotto la luce estiva frotte di carbonai risalivano dalla Ciociaria con le famiglie intere, il bosco il loro rifugio, dove ormai erano diventati esperti anche ad ammassare la pasta. Sempre forniti di uova perché si trascinavano dietro dalla valle le loro galline. Cavavano il carbone presso il vallone dello “Schapp’t” a ridosso di Monte Cappella:”Io andavo a portare tinozze d’acqua e in cambio mi rendevano una “soma” di legna. Per fare il piazzale alla montagna i carbonai mettevano tutte travi orizzontali per farsi spazio. La mia mula vi rimase incagliata e si ferì. Tutti dicevano di offrirla ai “carnacciari”. Ma mio padre Tatà Curr’ mi ordinò di andare a prendere la “crap’nella”, erba con cui si faceva il decotto che usammo per lavare la ferita. E dopo dieci giorni la ferita guarì. E tutti chiedevano come avessimo fatto il miracolo”. Racconta nonno con la foga di chi vuole seminare ricordi.
I carbonari facevano della cenere il loro giaciglio
Adesso che il paese non è più biondo come il grano, ma è plumbeo come il cemento che lo ha ferito, si è già consumata un’altra epoca, quella dell’avvicendarsi delle divinità. Abbiamo incrociato il nostro destino al Pil e alla Borsa, eppure con un biglietto verde in mano l’infelicità continua a tarlarci. “Ritorno alla terra” ha un’eco maoista, ritornare al terriccio non è più un sotterfugio per sfuggire al capitalismo ma indica il ritorno al “suolo”, una piattaforma che salva, della stessa materia di cui è fatto l’uomo.
Nonno mi trattiene:”Non andare via, e se vai via, ritorna!”. Ritorna, ritorno. Ci sono tante strade per riscappare al punto di partenza.
Da FEDE T, Pescasseroli, Abruzzo, Europa, Emisfero Boreale, Mondo